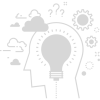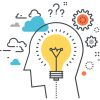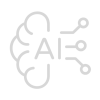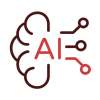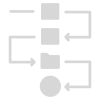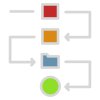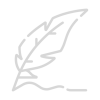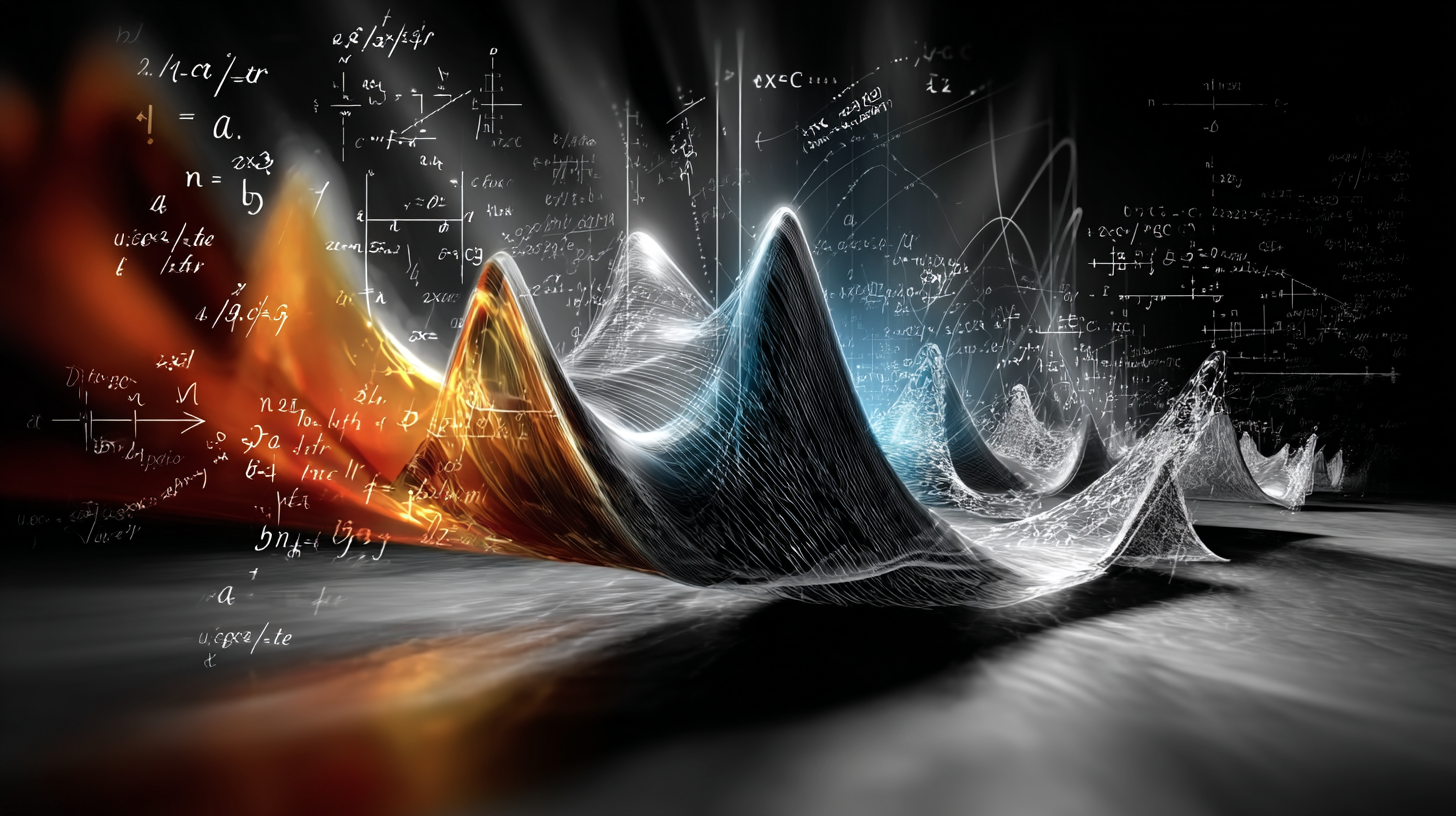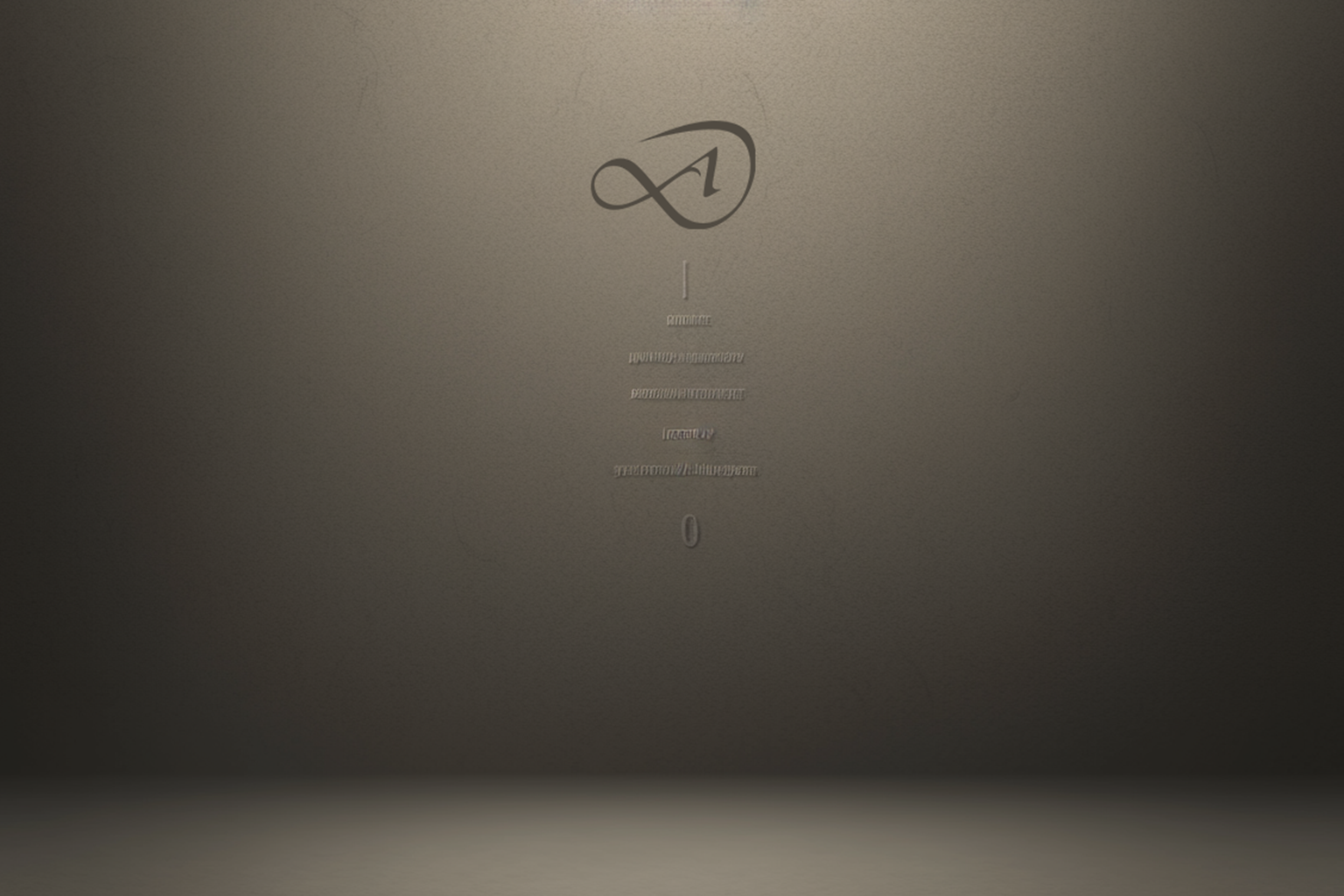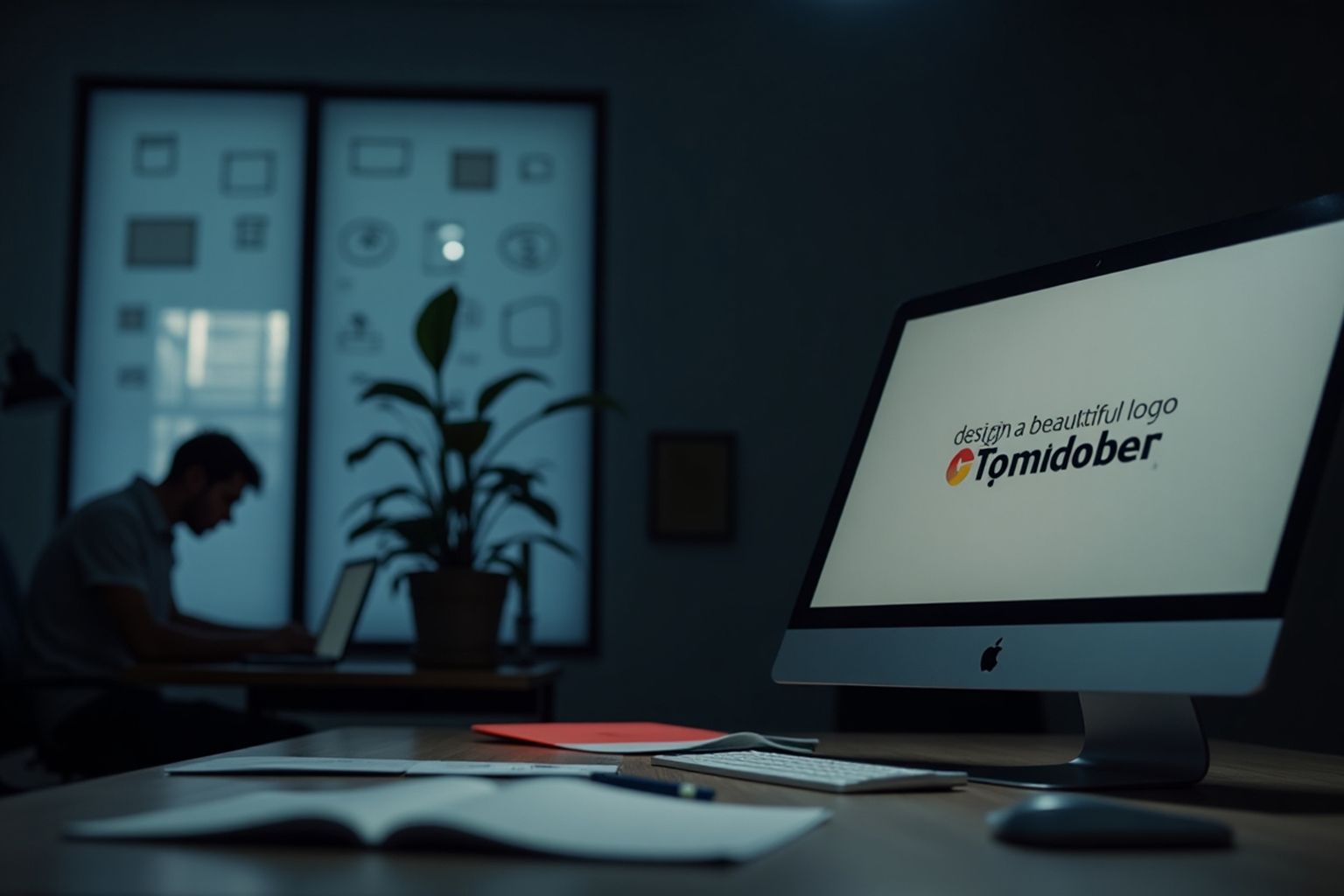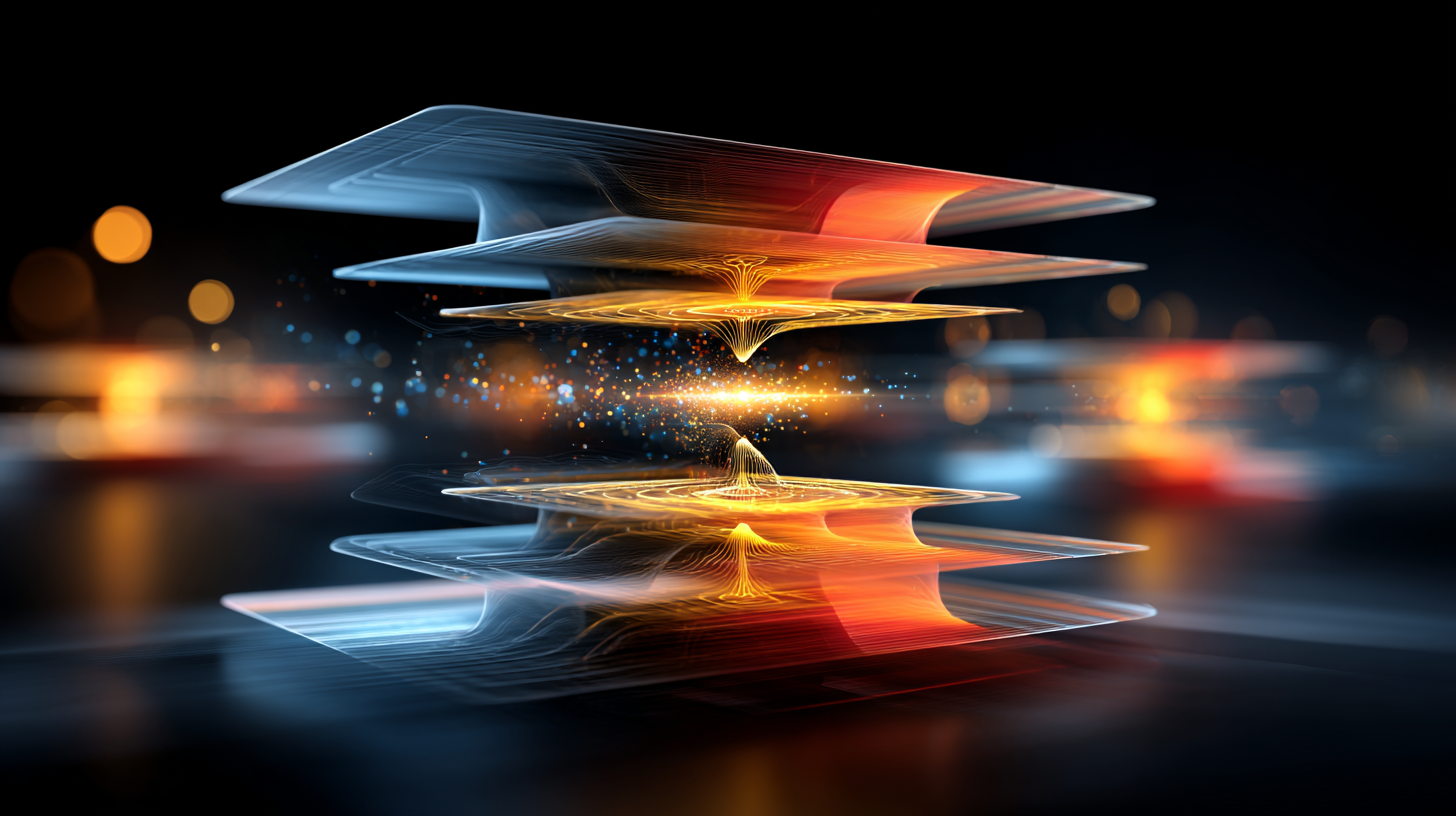
Semiotica Neogenerativa / Fondamenti
[Parte 2/3]: La precipitazione
Blur, parallasse e stratificazione: i miei strumenti operativi della Semiotica Neogenerativa.
Abstract [Parte 1/3]
Nel primo capitolo di questa trilogia, abbiamo tracciato le coordinate concettuali della Semiotica Neogenerativa: il segno come campo di possibilità, la Nuvola Semantica Gaussiana come spazio distribuzionale del senso, e la nozione di precipitazione come collasso interpretativo guidato. Abbiamo esplorato la forma del senso, la sua distribuzione, le sue traiettorie probabilistiche. Abbiamo visto come ogni messaggio occupi uno spazio — non un punto — e come questo spazio possa essere progettato, compresso, esteso o calibrato.
Se non hai ancora letto il primo articolo, puoi trovarlo qui:
Semiotica Neogenerativa / Fondamenti [Parte 1/3]: La forma del senso
Introduzione
01
Dalla teoria alla prassi: come stringere la varianza di un claim
Va bene la teoria, ma ad un certo punto bisogna sporcarsi le mani. Perché possiamo studiare tutte le gaussiane del mondo, ma se poi scriviamo "più veloce di sempre" su una landing page senza dire rispetto a cosa... stiamo solo deformando e quel che è peggio allargando la bolla.
Domanda obbligatoria: “rispetto a cosa?”
Ogni superlativo o assoluto — "grande", "enorme", "perfetto", "illimitato", "sicuro" — ha senso solo se ancorato a un riferimento chiaro. Altrimenti la curva esplode, si allarga troppo, e la precipitazione può ribaltare completamente l’effetto desiderato.
A volte però questo effetto è voluto. Alcuni claim funzionano proprio perché non ancorano in modo esplicito, lasciando spazio all'immaginazione, all'ambiguità interpretativa, o alla suggestione emotiva. Un esempio clamoroso e attuale? Make America Great Again. Nessuno ha mai chiarito rispetto a cosa dovesse tornare grande, né quando fosse grande davvero. Ma proprio questa vaghezza ha funzionato: ognuno ci ha proiettato dentro la sua personale nostalgia, la sua idea di grandezza perduta, il suo tempo mitico; insomma, ognuno c'ha messo dentro quel "grande" un po' quello che voleva. E la curva si è allargata verso significati multipli positivi e personali, in modo controllato e strategico, con l'effetto di amplificare il consenso, senza in fondo dire nulla di concreto.
Inoltre, avviene anche un’estensione laterale della bolla semantica. Il claim, implicitamente, suggerisce che "l'America era grande", che "qualcosa o qualcuno l’ha fatta decadere" e che ora, grazie a chi lo dice, "tornerà a esserlo". È un messaggio implicito a strati, con precipitazioni multiple che si distribuiscono lungo linee interpretative molto diverse: patriottismo, riscatto, rabbia sociale, identità, paura.
Nella vaghezza voluta e pilotata della precipitazione… c’è un mondo intero, se ci pensate.
Per completezza — e per par condicio — vale la pena citare anche un altro claim entrato nella storia: Yes We Can, lo slogan con cui Barack Obama vinse le elezioni nel 2008.
A prima vista, il confronto con Make America Great Again sembrerebbe facile da risolvere: uno guarda al futuro, l’altro al passato; uno inclusivo, l’altro identitario; uno progressista, l’altro conservatore. Eppure, sotto il profilo semiotico, i due claim funzionano esattamente allo stesso modo.
Entrambi non dicono cosa possiamo fare.
Non dicono come, quando, perché o rispetto a cosa.
Non definiscono contenuti, ma attivano emozioni.
Non stringono la varianza, ma allargano la curva.
E lo fanno in modo strategico, non ingenuo.
- Make America Great Again evoca un tempo mitico e perduto, e ognuno ci ha proiettato dentro la propria idea di “grandezza”: militare, morale, economica, culturale. C’è chi ha pensato alla potenza industriale degli anni ’50, chi alla famiglia tradizionale con la torta di mele sul davanzale, chi a un’epoca in cui si poteva dire tutto “senza che nessuno si offendesse”, chi semplicemente a quando la benzina costava meno e i jeans duravano dieci anni. Ognuno c’ha messo dentro il proprio “great”.
- Yes We Can invoca un potere condiviso e attivabile, ma senza specificare cosa possiamo fare: superare le crisi? cambiare il sistema? riscattarci da secoli di esclusione sociale e culturale? Tornare a iscriverci in palestra? Mangiare più sano? Lavorare di meno e guadagnare di più? Ognuno c’ha messo dentro il proprio “can”.
Ma se analizziamo dal punto di vista della Semiotica Neogenerativa, il parallelismo, tuttavia, è evidente: entrambi i claim operano dentro una Controlled Blur Semiosis, allargando la bolla semantica in modo calibrato per accogliere proiezioni personali, ma mantenere una convergenza emotiva. In questo modo la curva si apre, ma (in modo controllato) non si disperde. Non c’è un significato unico, tuttavia c’è una direzionalità condivisa. Non c’è coerenza logica, ma c’è una forte coerenza percettiva.
E alla fine, il meccanismo regge perché genera adesione, identità, senso e lo possiamo chiamare sogno americano o riscatto nazionale, per cui può cambiare il senso, ma alla fine la meccanica è la stessa.
02
Cornice lessicale e iconica coerente
Quando parlo di contesto non intendo qualcosa di esoterico o complicato: intendo processi semantici combinati, come l'incontro tra una parola e un’immagine. La parola serve a esplicitare il segno che deve veicolare il messaggio. Un'immagine in cui è inserito il messaggio serve a dare contesto, ovvero a restringere il raggio della bolla semantica il più possibile.
E da quel contesto, voglio che il segno non sfugga. Perché se sfugge, il raggio si modifica inevitabilmente, si allarga, si distorce.
Parola e immagine devono precipitare sullo stesso picco. Se scrivi "trasparente" e visualizzi una mano con un vetro opaco, puoi anche spegnere tutto: stai alzando la coda negativa. Perché è vero che il vetro è, per sua natura, trasparente. Ma se è opaco, il fatto che sia vetro non conta molto. Non se il messaggio che vuoi veicolare è davvero la trasparenza. Certo, ci sono anche casi in cui succede esattamente il contrario. Oppure altri in cui la banalità regna sovrana. Ma in generale serve coerenza narrativa che sostenga l’obiettivo comunicazionale e la stessa esistenza del segno come veicolo di un preciso significato.
03
Blur controllata
A volte, e in certi contesti e con certi interlocutori, un pizzico di ambiguità può essere utile perchè stimola curiosità, rende il messaggio più vivo e meno scolastico. Ma occhio: quello che io chiamo la Controlled Blur Semiosis va calibrata, e con attenzione, perché è facile che sfugga di mano, sfocianto spesso, quando va bene, nel sarcasmo, in altri casi nella contraddizione o nel falso.
Ecco alcuni esempi concreti:
- Se diciamo “Niente confini” per promuovere un servizio di spedizione, ma poi nei dettagli scopriamo che non consegna né in Svizzera né nei weekend, stiamo usando un blur che si sgonfia al primo click.
- Se scriviamo “Libertà assoluta” per una city car da 70 cavalli, con autonomia ridotta e parcheggio a pagamento, l’ambiguità non stimola: delude. Perché nella mente dell’utente, “libertà” evoca spazi aperti, autonomia, zero vincoli — e lì il contesto lo tradisce.
- Se lanciamo una piattaforma dicendo “Reinventa il tuo modo di lavorare”, ma poi scopriamo che si tratta dell’ennesimo tool per organizzare to-do list, la curva semantica si spacca tra promessa e realtà. Non è solo blur: è disallineamento semiotico.
- Se scrivi "Zero attriti" e mostri un'interfaccia ultra-minimal, il messaggio funziona. Ma se nella realtà ci sono 7 click per uscire dal servizio, o per arrivare al punto…. l'ambiguità ti si ritorce contro, perché siamo proprio disallineati con la realtà pratica.
In sostanza:
Troppa sfocatura = significato che si disperde in una bolla di precipitazione non solo troppo ampia, ma a volte fuori contesto, non verificabile, non vera.
Troppa rigidità = messaggio che non emoziona, troppo tecnico, poco visionario.
Per esempio: un e-commerce che descrive una felpa come "prodotto in cotone da 280gr, disponibile in 4 taglie e 3 colori" è più che corretto, ma l’impatto da un punto di vista “emotivo” è ZERO.
Oppure: un software che si presenta con "il nostro gestionale è conforme al regolamento xyz" è una specificità, una verità utile, ma di certo non è seducente.
Ecco che quindi risulta evidente il controllo del blur, il giusto “dosaggio”, il giusto grado di tensione, la giusta ironia, ecc… in modo da veicolare un messaggio “leggibile”, coerente, correttamente contestualizzato, verificabile, vero e distintivo. La creatività qui davvero non ha limiti.
E da questo punto di vista, ormai da decenni, la pubblicità su qualunque media gioca la sua credibilità ed efficacia proprio sulla sua capacità di saper calibrare il blur semantico. E non solo attraverso le parole, ma anche grazie a combinazioni narrative e associazioni di idee, spesso insospettabili, che mirano a generare non tanto e non necessariamente il bisogno del prodotto in sé, ma il desiderio del senso che si associa a tale prodotto attraverso la calibrazione del blur sul contesto e sul “segno”.
Per esempio, un motorino? Magari no. Ma la sensazione di indipendenza, appartenenza, desiderabilità? Quella sì, la desideriamo un po’ tutti, no?
Ecco che allora un ragazzotto fuori da scuola che aspetta la sua bellissima fidanzata accanto al suo scooter... pensaci un attimo: cosa esattamente sta cercando di venderci? Lo scooter? Davvero??!!... Certo, è quello che andremo a comprare. Ma di certo non perché vogliamo uno scooter…
Tuttavia, date queste premesse ed esemplificazioni, il blur semantico, se dosato bene, non è sinonimo di confusione o di “mischiare le carte”: può anche essere narrazione emotiva stratificata. E quando funziona, quando è davvero ben calibrato, non si dimentica, crea “imprinting”.
04
Prospettive multiple, stesso nucleo
Il controllo della precipitazione nella Nuvola Semantica consente anche di modificare le prospettive in modo naturale. Quello che io chiamo Parallax Semiosis. In sostanza è un modo per far funzionare in modo armonico il cambio di prospettiva.
Punti di vista differenti variano l'angolazione, la profondità, le simmetrie e le relazioni tra le parti, ma mantengono la stessa struttura funzionale: tengono il centro.
La bolla fluttua leggermente attraverso il Parallax Semiosis, ma mantiene la sua posizione nella Nuvola.
Claim: Auto ibrida
- Per l'utente comune, è "un'auto che consuma meno e inquina meno".
- Per un tecnico, è "un sistema di motorizzazione duale con gestione ottimizzata dei flussi energetici".
- Per un comunicatore, è "una scelta responsabile senza rinunciare alle prestazioni".
Claim: Comfort di una poltrona d'ufficio
- Per l'acquirente: "finalmente non mi viene mal di schiena dopo due ore".
- Per il designer: "materiali traspiranti, struttura ergonomica, microregolazioni".
- Per il marketing: "un'esperienza di lavoro immersiva e naturale".
Per entrambi gli esempi abbiamo tre punti di vista differenti, tre diverse interpretabilità, ma abbiamo uno stesso picco semantico. La bolla rimane stabile. Si cambia leggermente prospettiva, certo, ma la bolla rimane li dov’è.
Il Parallax Semiosis permette di usare più angolazioni senza perdere allineamento e se questo non dovesse succedere, allora significa che pubblici diversi ricevono messaggi diversi, la bolla si sposta e non è detto che l’interpetabilità porti a effetti comunque positivi o accettabili, la comunicazione non fa centro, c’è il boomerang, crea “fastidio” e quando la bolla si sposta in questo modo allora vuol dire che abbiamo perso il controllo e per un brand, per esempio, ciò si traduce in... potenziale disastro.
05
Stratificazione e trasparenza semiotica
La ThroughView Semiosis indica una modalità interpretativa in cui i segni non si esauriscono alla superficie, ma invitano a “guardare attraverso”, introducendo il concetto di trasparenza e opacità come strumenti per cogliere stratificazioni sovrapposte di senso. È un concetto affine alle velature pittoriche: ciò che appare in primo piano è solo una parte della composizione, mentre la vera esperienza si rivela percependo i livelli sottostanti. In termini sistemici, la ThroughView Semiosis si colloca accanto alla Blur e alla Parallax Semiosis: se la sfocatura governa l’ampiezza della bolla e la parallasse ne ridefinisce la forma in funzione della prospettiva, la ThroughView regola il grado di visibilità e di accesso ai diversi strati.
Questo approccio invita a progettare esperienze comunicative che incoraggino la scoperta, la profondità, il tempo e la memoria.
In termini pratici, parliamo quindi di profondità e di percezione di più strati validanti il processo semiotico. E, in generale, ogni esperienza comunicativa è pensata in fondo per essere esplorata in profondità, volente o nolente, rivelando cosa c’è sotto, cosa è dichiarato, cosa è misurabile e cosa è volutamente lasciato opaco.
Stratificare un messaggio significa decidere cosa far vedere subito (la superficie), cosa rivelare solo guardando meglio, con più attenzione e con più pensiero, e infine cosa svelare negli strati più profondi, dove è nascosta la nuda verità. Possiamo promettere qualcosa (efficacia, bellezza, velocità), misurare qualcosa (risultati, dati, prove), ma anche esplicitare i limiti: cosa non posso garantire, dove non posso arrivare, cosa non ho ancora risolto. E quando lo faccio bene, l’interlocutore percepisce, sente che il messaggio non è monodimensionale e/o monomodale, ma ha spessore. E l’effetto più diretto di quello spessore è la fiducia.
Ma attenzione: la stratificazione non significa fornire un elenco di KPI in piccolo sotto un asterisco. Significa costruire un messaggio con strati che si tengono insieme, in cui il lettore o l’osservatore percepisce che dietro ogni parola, dietro ogni "segno", c’è un’intenzionalità progettuale, un “perché”. Quando ciò è vero, quando dietro a ogni decisione, parola, gesto, immagine, forma o insieme compositivo c'è un "perché" di coerenza, di storia, di valori, di armonia, di contrasti e di trasparenza, anche se non esplicitata alla superficie, si crea un implicito legame di correlazione. Ed è proprio lì che nasce la fiducia. E’ li che brand storici con alle spalle decenni di “mercato” costruisco il proprio mito.
Conclusione
Contesto, sistema di riferimento, dinamiche evolutive nel tempo, Blur, Parallax, ThroughView Semiosis: ecco perché dal mio punto di vista, progettare comunicazione non significa di certo solo saper scrivere bene, saper costruire siti web che funzionano o brochure allineate al brand. Anzi, significa saper modellare la curva, stringere la varianza, creare stratificazioni, modulare i punti di vista e decidere di far precipitare il senso esattamente lì dove vogliamo che precipiti. E forse è proprio qui che la semiosi diventa design: non solo cosa "diciamo", ma cosa scegliamo di lasciar emergere.